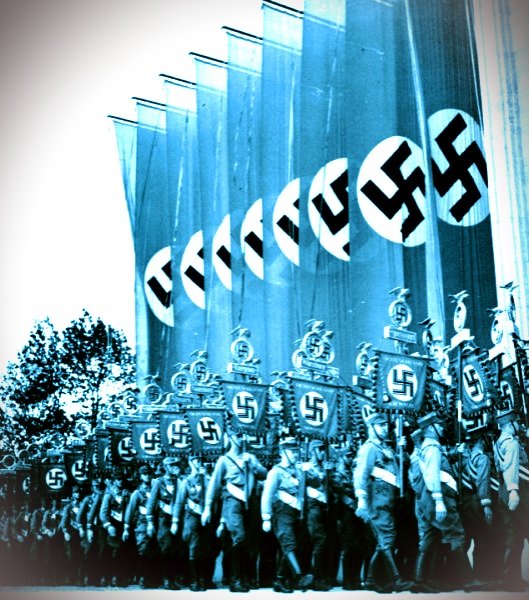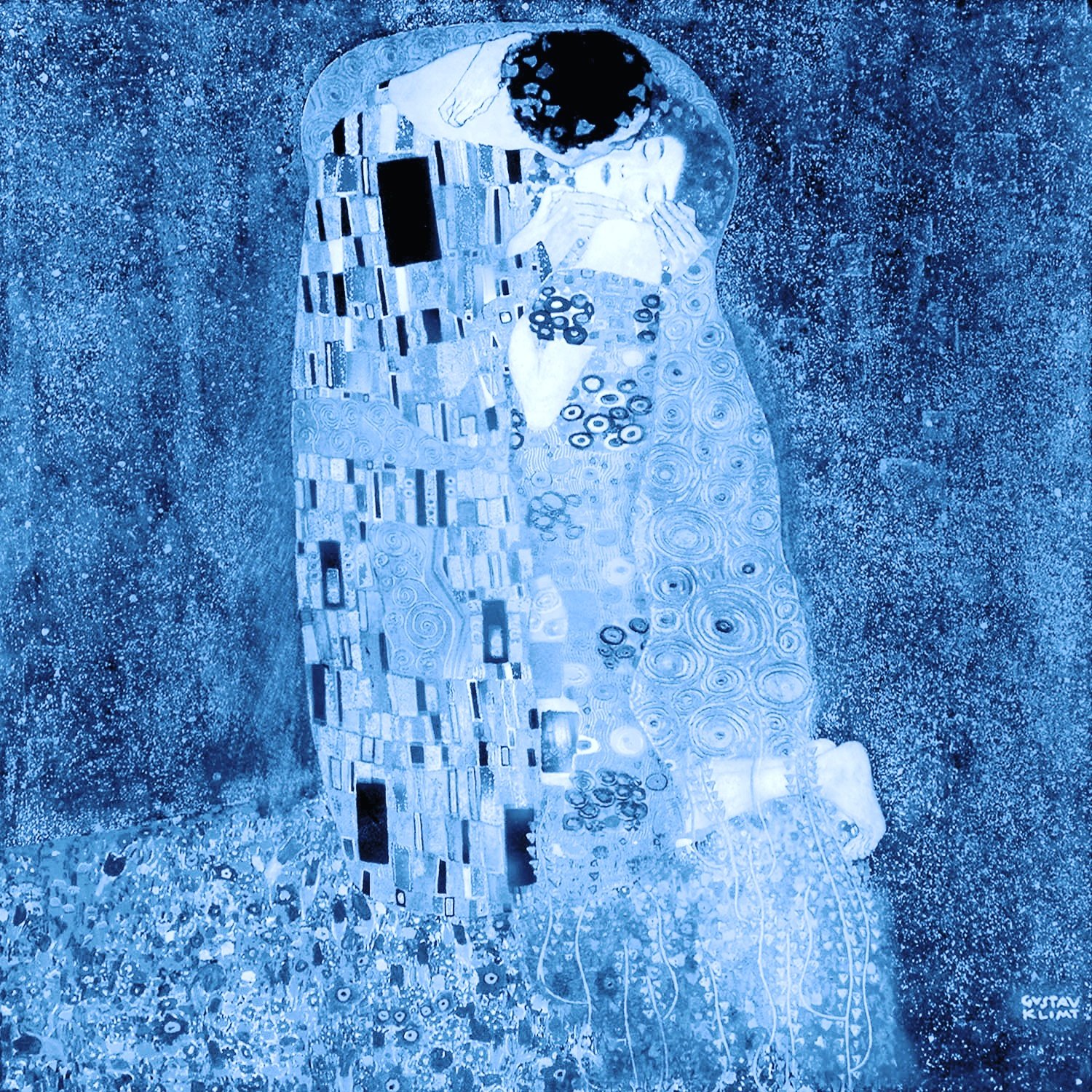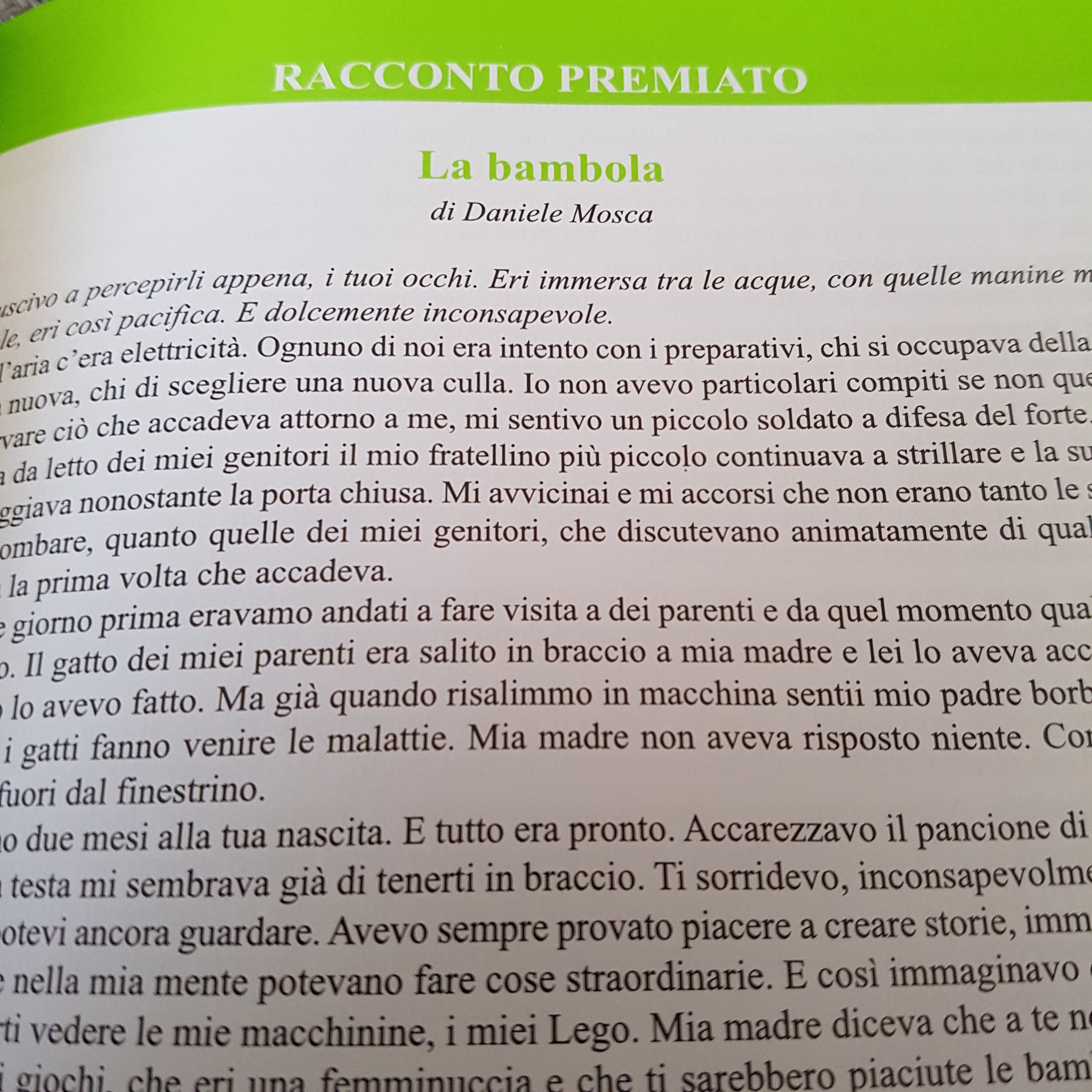Autore: Daniele Mosca
Presentazione ufficiale de #LaMacchinadelSilenzio
Ambientazioni
Il confine
Uccide, senza uccidere
#LaMacchinadelSilenzio
Nulla sarà mai più come prima
La Macchina del Silenzio ora è realtà
Ci è voluto un po’ di tempo, ma #laMacchinadelSilenzio non è un hashtag qualsiasi, bensì il titolo del mio nuovo romanzo. Les Flâneurs Edizioni ha scelto di investire anche questa volta su di me e per questo ringrazio Alessio Rega. Presenteremo il nuovo lavoro in una delle librerie più affascinanti di Torino, Fenice Libreria – Torino il 14 ottobre.
Siete pronti?
Su questa pagina Facebook troverete tutti i prossimi aggiornamenti:
La Macchina del Silenzio di Daniele Mosca
E ovviamente su tutti gli account facebook, twitter e instagram che già conoscete e sul danielemosca.com
La bambola
Un racconto a cui sono molto legato è stato inserito nella raccolta #raccontidinascite pubblicato da AslTo5. Si chiama la bambola. Eccolo…
LA BAMBOLA
Riuscivo a percepirli appena, i tuoi occhi. Eri immersa tra le acque, con quelle manine minuscole, eri così pacifica. E dolcemente inconsapevole.
Nell’aria c’era elettricità. Ognuno di noi era intento con i preparativi, chi si occupava della stanzetta nuova, chi di scegliere una nuova culla. Io non avevo particolari compiti se non quello di osservare ciò che accadeva attorno a me, mi sentivo un piccolo soldato a difesa del forte. Nella stanza da letto dei miei genitori il mio fratellino più piccolo continuava a strillare e la sua voce riecheggiava nonostante la porta chiusa. Mi avvicinai e mi accorsi che non erano tanto le sue urla a rimbombare, quanto quelle dei miei genitori, che discutevano animatamente di qualcosa. E non era la prima volta che accadeva.
Qualche giorno prima eravamo andati a fare visita a dei parenti e da quel momento qualcosa era cambiato. Il gatto dei miei parenti era salito in braccio a mia madre e lei lo aveva accarezzato. Anche io lo avevo fatto. Ma già quando risalimmo in macchina sentii mio padre borbottare sul fatto che i gatti fanno venire le malattie. Mia madre non aveva risposto niente. Continuava a guardare fuori dal finestrino.
Mancavano due mesi alla tua nascita. E tutto era pronto. Accarezzavo il pancione di mia madre e nella mia testa mi sembrava già di tenerti in braccio. Ti sorridevo, inconsapevolmente. Anche se non mi potevi ancora guardare. Avevo sempre provato piacere a creare storie, immaginare personaggi che nella mia mente potevano fare cose straordinarie. E così immaginavo di portarti al parco, di farti vedere le mie macchinine, i miei Lego. Mia madre diceva che a te non sarebbero piaciuti quei giochi, che eri una femminuccia e che ti sarebbero piaciute le bambole. In quel momento però non mi sembrava una cosa poi così importante. Accarezzai ancora una volta la panciona che ti teneva al riparo dal mondo. In quel momento però notai qualcosa di strano sul viso di mia madre, delle venature che le solcavano il viso. Sembrava sofferente. Cercai mio padre nelle altre stanze, ma non c’era. Mi ricordai che era ancora al lavoro e che sarebbe arrivato da lì a poco. Lui sicuramente avrebbe saputo cosa fare.
Tornando a casa da scuola, mi piaceva passeggiare per le strade, anche se dovevo percorrere un tragitto di pochi isolati. Quel giorno suonai il campanello ma nessuno mi rispose. Che strano, pensai, a quell’ora in genere era già pronto il pranzo. E invece dal citofono non provenivano voci e il portone non si apriva. Qualche istante più tardi vidi comparire mio padre, trafelato. Aprì il portone senza dire niente e mi fece cenno di entrare. Il suo viso sembrava diverso. Salimmo le scale in silenzio. Aprì la porta di casa ed entrammo. Tra le mura regnava un silenzio spettrale.
“Dov’è la mamma?” sussurrai. A dire il vero non sembrava nemmeno una domanda, ma quell’interrogativo sembrò riecheggiare nelle stanze tornando indietro con un sapore fin troppo amaro rispetto a quando era partito.
“È in ospedale.”
“Ma non è presto?” replicai.
Osservai mio padre che sembrava non voler rispondere al mio sguardo.
“Che succede?” continuai. Nessuna risposta.
Mio padre mi preparò della pasta, ma non riuscii a mangiare niente. Anche lui non toccò cibo. Più tardi andammo a prendere mio fratello all’asilo.
“Posso venire anche io a vederla?”
“Non ti fanno entrare” mi rispose mio padre. “Devi restare a casa per un po’ con tuo fratello, torno presto” disse poco prima di scomparire oltre la porta di casa.
In quel momento riuscii a percepire il silenzio massacrante, quello che poteva superare di molto il pianto del mio fratellino. Quello che ti entra dentro. E che inizia a scavare.
Pochi giorni più tardi arrivarono i miei nonni, ma l’atmosfera era cupa, distante anni luce da quella che si respirava in estate quando ci rincontravamo. Li sentivo parlare a bassa voce, continuavano a ripetere senza sosta è colpa sua.
I discorsi che riuscivo a captare erano frammentati e nessuno mi raccontava mai nulla nel dettaglio. Rimanevo in silenzio per ore, come se riunendo quei frammenti riuscissi a vedere un quadro, un’immagine. Una spiegazione. La mamma stava male.
Una di quelle sere mi avvicinai a mio padre intento a evitare di sedersi a tavola con i miei nonni e rimasi a osservarlo.
“Domani la operano” esclamò. Quelle parole così secche e asciutte mi sembrarono un fendente violento che si insinuava dentro di me, ben oltre la mia pelle, mostrando una consapevolezza che si stava svelando in tutta la sua ferocia.
“È presto” dissi a me stesso. Senza capire cosa esattamente mi stesse facendo formulare proprio quel pensiero. Io sapevo che un bambino nasce dopo nove mesi. E invece ne mancavano ancora due.
Il giorno seguente non andai a scuola. Verso il primo pomeriggio mi recai con i miei nonni in ospedale. Una struttura che sembrava enorme, ai miei occhi. Mi dissero che anche io ero nato in quell’ospedale. Attraversammo interminabili corridoi e incrociammo decine di personaggi bianchi e azzurri con lo sguardo che mi sembrava assente. Tutti erano intenti nel far qualcosa che non capivo. Ci dissero di sederci in una sala dalle pareti bianche e l’odore di disinfettante. Mi limitavo a osservare le piccole pietre stampate sulle piastrelle. Sembravano tutte diverse, ma mi accorsi che invece si ripetevano. Quelle pietre erano tutte uguali.
“Potete entrare” comunicò un infermiere.
Il mio sguardo si aggirò smarrito cercando di incrociare quello dei miei nonni e di mio padre. Quest’ultimo mi prese per mano, incurante delle proteste dei miei nonni. Ed era il segnale insperato: sarei entrato anche io.
Mia madre era bianca in viso, coperta da una vestaglia a sua volta bianca. Mi strinse la mano, anche se la parola stringere è un eufemismo. Allora non sapevo cosa volesse dire questa parola, non sapevo tante cose, ma una era sempre stata una mia prerogativa. Leggere gli sguardi. E in quello di mia madre c’era qualcosa che non riuscivo a capire del tutto. Sembrava spento, lontano. Con la coda dell’occhio vedevo mio padre parlare con un medico.
“È nata?”
In quel momento il medico ci chiese di uscire dalla stanza.
Non credevo che sarebbe successo, che mi avrebbero portato a vederti. Eri nata e mia madre si era salvata, per poco. Ci sarebbe voluto ancora tanto tempo perché si riprendesse. Il medico aveva detto che forse l’interruzione di gravidanza era stata causata da un’infezione di origine felina. Né tu, né il medico sapevano che dopo quel giorno i nostri genitori si sarebbero allontanati per sempre. Riuscivo a percepirli appena, i tuoi occhi. Eri immersa tra le acque, con quelle manine minuscole, eri così pacifica. E dolcemente inconsapevole, che la vita è un soffio. E quando si nasce, si nasce per sempre. E anche se adesso conosco più parole, se ti ho vista per un solo attimo e so che siamo tutti piccole pietre uguali le une alle altre, se ora stringo ancora questa bambola che avrei voluto regalarti, io non ti ho mai dimenticata, Laura.